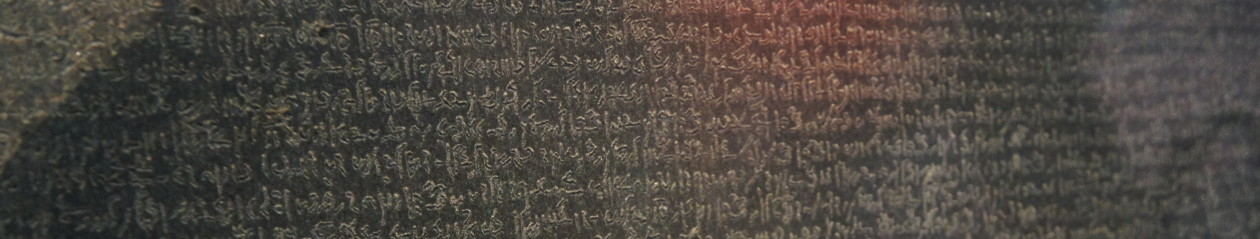ATTUALITA’: STORIA E MEMORIA – I FASCICOLI DEI LAGER NAZISTI / L’archivio della Shoah resta chiuso: l’Italia non ha ancora ratificato gli accordi. Una scandalosa resistenza che dura da anni. Perché quei dossier fanno ancora paura.
Sull’identità e sui destini personali delle vittime dell’Olocausto la storia non ha ancora finito di fare i conti. Perché la ricerca della verità si ferma al portone di un palazzo della cittadina di Bad Arolsen, una vecchia caserma delle Ss dove è custodito il più grande archivio sulla Shoah: 50 milioni di documenti, ospitati lungo 26 chilometri di scaffali con un’infinità di dati sulla sorte di 17 milioni e mezzo di vittime della Germania nazista. È lì, per intenderci, che si conservano la scheda redatta dagli aguzzini di Anna Frank e l’originale della famosa Schindler’s List. Ma anche i dati di tanti italiani deportati. Lì è murata anche la speranza di conoscere spesso l’ultimo desiderio per i sopravvissuti ai lager, la cui generazione va scomparendo. E tuttavia la loro è un’attesa che proprio l’Italia rischia di rimandare con una serie di rinvii scandalosi che stanno rendendo insostenibile la posizione dei nostri governi davanti alla comunità internazionale: finora infatti il nostro Paese è l’unico a non avere nemmeno indicato quando ratificherà gli accordi sull’archivio, impedendone così l’apertura.Dal 1955 la gestione di quella montagna di documenti è regolata da un complesso accordo, che li ha affidati all’International Tracing Service (Its) di Bad Arolsen, braccio della Croce rossa internazionale: la responsabilità spetta a 11 paesi: Italia, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Israele. Paesi che nel luglio scorso, di comune accordo, hanno deciso di aprire gli archivi al pubblico. Ma la volontà politica deve trovare anche un riscontro formale. E proprio l’Italia è uno degli ultimi membri a dover ancora completare l’indispensabile processo di ratifica. L’unico, come ha sottolineato persino il ‘New York Times’, a mostrare un’inspiegabile “resistenza passiva”.
Rispunta l’Asse
Le resistenze italiane hanno inizio nel 2002 e appaiono subito controtendenza, perché nascono parallelamente alle pressioni americane e israeliane su Berlino per l’apertura degli archivi. Di fatto, in nome della privacy rinasce l’Asse: per diversi anni le nostre autorità si alleano a quelle tedesche, formalmente preoccupate per la tutela della riservatezza dei dati personali. A Roma, poi, la pratica era affidata al ministero della Difesa, come se la memoria dell’Olocausto fosse una questione militare. Paul Shapiro, direttore del centro studi dell’Holocaust memorial Museum di Washington, racconta di una forte contrapposizione in seno alla Commissione fra chi spingeva affinché la decisione di aprire Bad Arolsen fosse presa a maggioranza e chi, invece, a partire dall’Italia, invocava l’unanimità. Assicurandosi così una specie di diritto di veto. Non è solo in quella sede che l’Italia ha agito controcorrente. Nell’autunno 2005 la comunità ebraica romana decide di coinvolgere il sindaco della capitale. Walter Veltroni il primo dicembre scrive ad Antonio Martino, allora responsabile della Difesa, chiedendo che “il contributo dell’Italia possa andare nella direzione di un’apertura”. La risposta è in puro burocratese: il ministro si limita a indicare come ‘referente’ l’allora rappresentante italiano all’Its, il tenente colonnello Sandro Tortora. Peccato che Tortora nell’unica uscita pubblica, nel febbraio 2006, abbia espresso più di un dubbio sul libero accesso: “Negli Usa vigono norme sulla privacy più flessibili, quindi non ci sarebbe più alcuna garanzia a tutela dei nomi che verrebbero fuori”.Nell’aprile 2006, poi, il colpo di scena: la Germania cede alle pressioni Usa. Il ministro della Giustizia tedesco, Brigitte Zypries, nell’annunciare il cambio di linea del suo governo passa quindi la palla alle autorità italiane, che finora “hanno fatto resistenza”, e devono “ancora essere persuase”. Il mutamento di scenario costringe l’Italia ad adeguarsi, tanto che a luglio l’ambasciatore a Berlino Puri Purini firma gli emendamenti agli accordi di Bonn che sanciscono la libera consultazione. Tutto fatto? No. A quel punto la responsabilità dell’affaire cambia padrone, dalla Difesa agli Esteri. E il processo di ratifica stenta a partire. Soprattutto negli Usa si individua il governo di Roma come il principale ostacolo sulla strada della verità. Nel dicembre 2006 Joe Biden, presidente della commissione Esteri del Senato, scrive all’ambasciatore Gianni Castellaneta sollecitando l’intervento italiano. Quattro mesi dopo scende in campo Hillary Clinton con una risoluzione volta a premere nei confronti dei paesi ancora in ritardo: Italia, Grecia, Francia e Lussemburgo. In realtà Parigi e il Granducato hanno già annunciato la ratifica come imminente: in coda ci sono Roma e Atene. “Non ci sono scuse per ulteriori ritardi”, ribadisce il senatore Biden.Se a Washington l’attenzione è altissima, nei palazzi del potere romano si pensa ad altro. L’unico a muoversi è Lucio Barani, deputato del nuovo Psi, che presenta un’interrogazione a D’Alema. A riferire in aula c’è però il ministro per i rapporti col Parlamento, Vannino Chiti, che si mantiene sul vago: “Abbiamo avviato le procedure di concerto interministeriale per poter predisporre un disegno di legge di ratifica dei protocolli”. Cosa significa? All’attuale ritmo di lavoro delle Camere ci potrebbero volere anni prima di arrivare al capolinea. La risposta di Chiti fa il paio con la posizione ufficiale della Farnesina, che non fissa scadenze. Non stupisce, quindi, come alla riunione annuale dell’Its, 15 giorni fa, l’Italia non sia riuscita a prendere un impegno preciso, indicando solo un generico, quanto ottimistico, “fine anno”. Tanto che l’ambasciatore Kennedy, inviato speciale del dipartimento di Stato Usa per l’Olocausto, ha avvertito che il suo governo vigilerà sugli Stati inadempienti. “I sopravvissuti aspettano di esaminare quei documenti da sessant’anni. È un tempo fin troppo lungo”, ha scritto Sara J. Bloomfield in una lettera pubblicata dal ‘New York Times’.
Criminali in fuga
In assenza di una spiegazione ufficiale di questa resistenza, pare lecito chiedersene il perché. Paul Shapiro, uno dei massimi esperti mondiali, ricorda come alcuni paesi abbiano a lungo preferito far calare il silenzio, non avendo un’idea su che genere di documenti si trovassero a Bad Arolsen: lì da decenni ogni foglio è stato catalogato, ma non è mai stato permesso agli storici di esaminarli e quindi interpretarne i contenuti. In quei dossier c’è qualcosa che fa ancora paura? Nei fascicoli ci sono elementi per individuare le tracce lasciate da criminali di guerra, quelli già noti e altri sfuggiti per sessant’anni alle indagini. Ed è altrettanto evidente, come spiega Shapiro, che si potrà fare luce sulle connivenze che in molti casi ne agevolarono la fuga. Soprattutto passando da Genova, snodo di una delle rotte più importanti: quelle vie di fuga naziste su cui, lo ha sottolineato lo storico argentino Uki Goñi, molto c’è ancora da scoprire, e molto è stato fatto per coprire.
Tra 50 milioni di file un solo caso è emerso finora. Quello del vescovo ortodosso Viorel ‘Valerian’ Trifa, il cui passato nella Guardia di ferro rumena lo vide responsabile del sanguinoso pogrom di Bucarest del ’41, poi ospite in Germania protetto dai nazisti, e infine insegnante di storia antica presso un istituto cattolico in Italia, dove almeno un alto prelato si interessò per garantirne lo status di ‘displaced person’, permettendogli così l’espatrio negli Usa. Già il processo del novembre 2000 a carico di Michael ‘Mischa’ Seifert, l’aguzzino del lager di Bolzano, aveva dimostrato l’importanza dei dossier di Bad Arolsen: l’approdo in Canada del torturatore è stato ricostruito proprio grazie a una lista d’imbarco scoperta in quell’archivio.
Santa lobby
Su questo punto Efraim Zuroff, erede dello storico cacciatore di nazisti Simon Wiesenthal, che già aveva smascherato Trifa durante la sua permanenza in America, avanza un’ipotesi provocatoria: la Santa Sede avrebbe discretamente esercitato la propria pressione politica sull’Italia. Dichiara il direttore della sede israeliana del Wiesenthal center: “Potrebbe essere stato il Vaticano ad aver convinto gli italiani a opporsi all’apertura degli archivi, per coprire i nomi di quei preti che si resero complici della fuga dei nazisti”.
Il materiale riguardante la fuga dei gerarchi hitleriani non è tuttavia l’unica documentazione ‘sensibile’ a toccare l’Italia. C’è anche un aspetto economico. L’indizio ce lo forniscono le assicurazioni Generali, impegnate a chiudere la partita delle polizze sulla vita dei dispersi dell’Olocausto. Non è una questione da poco: pressata dalle class-action intentate negli Usa, la compagnia triestina ha già messo a disposizione 135 milioni di dollari per fronteggiare 5.500 richieste di indennizzo. A febbraio gli avvocati hanno ottenuto che il termine per le istanze fosse prolungato fino all’agosto 2008, proprio in attesa di esaminare i documenti di Bad Arolsen che potrebbero far emergere elementi utili per nuove cause. Per non parlare, poi, dei tanti ebrei e non ebrei italiani che furono costretti ai lavori forzati, e quindi oggi idonei a presentare richieste di risarcimento agli Stati che ospitavano i campi di lavoro. Le prove però sono soltanto a Bad Arolsen.
Infine, l’ultima ipotesi, quella che vede protagonista un antico male italiano: la colpa è solo della tradizionale chiusura della nostra burocrazia. La stessa che seppellì nell”armadio della vergogna’ i documenti sugli eccidi tedeschi commessi in Italia, impedendo di fare giustizia su centinaia di vittime. Non trova altre spiegazioni Michele Sarfatti, direttore del Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano: “La burocrazia, e non solo in Italia, spesso ostacola tutto ciò che è nuovo e rappresenta un cambiamento. Forse è per questo che il processo d’apertura di Bad Arolsen è così lento. Del resto non voglio pensare ad altre possibili giustificazioni”.
(L’Espresso, 1/6/2007)