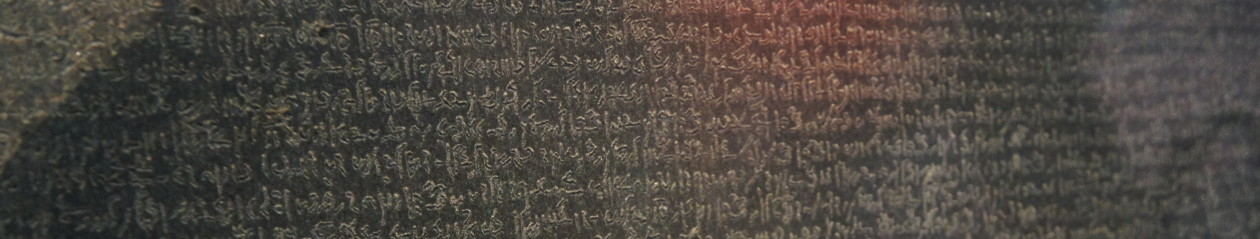di Roberto Saviano, L’Espresso
PRIMO PIANO / Rompere il rapporto tra cosche e politica. Distruggere il fascino dei boss. E combattere l’asse Italia-Usa. Questa la strategia con cui l’Fbi ha neutralizzato i clan. Spiegata da Joe Pistone, l’agente segreto immortalato da un grande film. Colloquio con Joe Pistone alias Donnie Brasco.
Meglio vedersi tra la gente, diamo meno nell’occhio… Joe Pistone non è proprio tranquillo, quando è in Italia, guarda le facce che gli sono attorno, tiene un tono di voce basso, è in uno stato di allarme, ma lo gestisce serenamente. Niente di nuovo per la sua vita. Aspetto fuori dal ristorante. Joe non si vede. Joe Pistone è una sorta di icona vivente, un agglomerato di leggenda che cammina, e sono abbastanza in ansia. In ansia di trovarmi dinanzi al suo talento. Un talento tragico, complesso.
Ciò che per me resta il mistero di Joe Pistone è la sua capacità di mimetizzarsi, di trasformarsi, di credere alla sua recita. O meglio: di dividere la propria anima in compartimenti stagni al punto da far emergere il peggio di sé non come qualcosa di esterno, ma come una sfaccettatura che ne è parte. Passano troppi minuti, provo a entrare. Joe è in un angolo. Spalle al muro. È seduto al tavolo, snocciola olive e si sputa in mano i noccioli. Lo stavo aspettando fuori dal ristorante e lui era dentro da un pezzo. “Meglio aspettare seduti a mangiare che fuori in piedi, a meno che non vuoi giocare al bersaglio”. Con me c’è Stefano Pitrelli che registra tutto, ci aiuta nella traduzione. È in ansia anche lui per l’incontro. Ma fingiamo di essere soltanto interessati a capire meglio ciò che ci dirà Joe. Stefano è vestito elegantissimo. Io come il solito. Pistone mi saluta e mi guarda: “Difficile che un italiano si vesta male come te”. Joe Pistone è Donnie Brasco, il personaggio divenuto celebre attraverso il film di Mike Newell. In realtà quel nome per molti anni era stato quanto di più segreto potesse esistere. Un nome noto soltanto tra gli affiliati del clan Bonanno e soprattutto all’Fbi.
E nell’Fbi solo un gruppo ristretto sapeva che Donnie Brasco era il nome di copertura dell’agente infiltrato per sei lunghissimi anni nella famiglia più potente di New York. Joe sembra il contrario di Johnny Depp, forse c’era persino più somiglianza fra Al Pacino e Lefty, il mafioso che fece entrare Donnie nel clan credendolo un commerciante di pietre preziose. Ma Joe è chiaro: “Il film è un film, la mia vita è la mia vita”. Si inizia a discutere.
“Sai”, dice Joe, “a New York la mafia aveva grande potere nel settore delle costruzioni. E nel settore dei rifiuti, monopolizzava praticamente questi due mercati. Ci riusciva attraverso il controllo dei trasporti, dei sindacati e attraverso il rapporto con la politica. Ora questo – anche attraverso duri colpi della polizia – non c’è più o non è così forte la loro presenza. Ora tutto è cambiato. Le giovani generazioni vogliono tutto subito. E ci riescono con la droga, è così che si fanno i soldi veloci, no? La mia generazione, quando io mi sono infiltrato, trattava la droga, ovviamente, ma erano solo i boss a controllarla. La regola era: niente droga nel quartiere. La vendiamo ad Harlem. Ai neri. O ai ricchi figli della New York fighetta. Ma niente nelle nostre zone. Mentre alle nuove generazioni non importa, perché il denaro lo vogliono oggi, subito. Loro stessi ne fanno uso: in passato era impossibile in una famiglia mafiosa che il boss e i suoi più stretti collaboratori sniffassero coca. Per tutte queste ragioni c’è grande attrito tra le vecchie e le nuove generazioni. Una sorta di conflitto generazionale. I nuovi clan hanno perso il controllo sui sindacati, perché le nuove generazioni non hanno l’esperienza e la capacità diplomatica di corrompere i politici come invece sapevano fare i loro padri. Sarebbe un lavoro troppo lungo. E loro vivono nell’immediato. I giovani non hanno capacità politiche. Una volta persi i sindacati si è perso anche il controllo sul commercio del Paese. Perso il controllo dell’industria dei trasporti su ruote, che il commercio lo muove, non è più possibile controllare i prezzi”.
La cosa strana per Joe Pistone è il potere fortissimo che i cartelli italiani continuano ad avere in Italia e nel mondo. Tutte le mafie del mondo si ispirano come modello, logica, azione, investimento a quella italiana, anche se a New York gli italiani da anni hanno delegato ad albanesi, nigeriani, e soprattutto russi il controllo del territorio. Joe mi ha chiesto di portargli una copia americana di ‘Gomorra’ e lui gira il libro cercando di nascondere la copertina, un ennesimo gesto di prudenza. E poi mi fa: “Ma tanto questa copertina americana in Italia non la conoscono, vero?”.
Quando si è trovato a parlare davanti al Senato statunitense per relazionare della sua attività di infiltrato, Pistone ha detto che i mafiosi quanto più si americanizzavano tanto più si allontanavano dalla mentalità mafiosa. Più gli Usa gli entravano nelle vene, meno divenivano affidabili. “Sai, negli Stati Uniti il clan Bonanno a un certo punto chiamò molti dalla Sicilia, era un modo di essere più sicuri. Il boss Carmine ‘Lilo’ Galante all’epoca importò mafiosi siciliani negli States. Ebbe la preveggenza di capire quale direzione stavano prendendo i giovani italoamericani, che stavano perdendo la loro ‘cultura’. La terza generazione si stava infatti ormai allontanando. Ecco perché portò direttamente in America la mafia siciliana che gli era più leale. Sapeva che i mafiosi siciliani avrebbero potuto andarsene in giro per l’America e ammazzare in libertà, perché una volta arrestati, nessuno avrebbe saputo chi erano. E poi erano più affidabili: niente droga, niente stravaganze. Disciplina e onore”.
Joe nei sei anni in cui è stato infiltrato ha visto l’intero organigramma del clan strutturarsi. “Col tempo i siciliani divennero molto potenti, tanto che oggi dentro ai Bonanno trovi due fazioni: siciliani e americani, che non si vedono di buon occhio. Gli americani erano gelosi dei siciliani importati da Bonanno, e i siciliani giudicavano gli americani troppo soft. Perché gli americani non uccidevano poliziotti o politici, mentre in Sicilia non avevano di questi scrupoli. Successe infine che il boss Galante fu ammazzato. E agli americani toccò formare una stretta alleanza coi siciliani, cui vennero promesse posizioni di potere dentro la famiglia Bonanno”.
Ogni tanto mentre parlo mi dimentico di star dinanzi a Donnie Brasco. Ci lasciamo andare ai discorsi sui massimi sistemi criminali. Sino a quando gli dico:”Joe sai che dalle mie parti sei un mito per ogni parte della barricata. I carabinieri ma anche i ragazzi di camorra. Donnie Brasco è Donnie Brasco perché ha le palle. Il resto vale zero in certe logiche”. Joe ride e commenta: “Forget about it!”, la mitica frase del film che tutti i gangster ripetono di continuo e che tutti i ragazzini dalle mie parti si ripetono imitando le espressioni di Al Pacino e Johnny Depp. L’hanno tradotta con ‘che te lo dico a fare’. La Porsche è una grande macchina ‘e che te lo dico a fare’, gli Yankees hanno un pessimo battitore ‘ma che te lo dico a fare’, Alicia Keys ha il più bel sedere del mondo ‘che te lo dico a fare’. Un’espressione che conferma. Conferma tutto e il contrario di tutto.
Chiedo a Joe Pistone se quando era infiltrato ha mai ricevuto ordini di morte. E lui ripete ironicamente “forget about it!”. Più volte fu mandato a uccidere delle persone, ma racconta di essere sempre riuscito a sottrarsi. “Mi sono stati assegnati dei ‘contratti’. E ho dovuto dire di sì: non puoi rifiutare, altrimenti ti ammazzano. E lascia che ti dica questo: se si fosse trattato di scegliere tra me e un mafioso, sarebbe stato lui. L’avrei ucciso. Ma è una situazione in cui non mi sono mai trovato. Un giorno stavo con altri mafiosi al club dove ci si ritrovava. Arriva una telefonata e la persona al telefono mi dice che l’uomo che dovevo uccidere era a un certo indirizzo. Gli altri mi hanno detto: ‘Ok, ora andiamo a beccarlo’. Ho capito che non potevo uscirne, perché se fossimo andati lì e io non l’avessi ucciso, mi avrebbero fatto fuori loro. Quindi capii che doveva morire. Ma quando stavamo per uscire arrivò un’altra telefonata, e mi dissero che quelle informazioni erano fasulle. Per cui non ci andammo. Ma sapevo che dovevo sempre tenere a mente ciò che ero disposto a fare per salvarmi la vita”.
Tenere a mente chi era. Questa la cosa più difficile. Tenerlo solo nella mente e non nel petto, nello stomaco. Dentro doveva essere Donnie Brasco, non Joe Pistone. Lontano per sei anni dalla famiglia, sei anni in cui se confessi a te stesso chi sei davvero commetti errori, sbagli, imprecisioni, ti rendi scrupoloso e morale. Il contrario di quanto occorre. Sei anni in cui devi prendere registrazioni, annotare facce, umori, comprendere cosa ti sta accadendo e cosa ti accadrà. Joe cerca di farlo avendo fede. Una fede nel destino – come dire: tutti prima o poi moriremo, quando sarà il mio turno non potrò farci niente, ma prima che questo momento arrivi, potrò fare di tutto per vivere. “Una volta, un tipo mi squadra: ‘Se non ci convinci di essere davvero un ladro di gioielli ti ritroveranno avvolto in un tappeto’. Ho dovuto salvarmi con le parole, senza lasciar trapelare nessun tipo di ansia, come dire: ‘Se vuoi farmi fuori fallo pure, io sono qui’.
In un’altra occasione, un tipo mi accusò di aver rubato al clan dei soldi provenienti dalla droga. Per stabilire se era vero, convocarono delle riunioni. Se in quei casi ti prende il panico, ti portano a ‘fare un giro’, ossia fuori città e poi ti regalano un proiettile alla nuca. Così invece di allontanarmi per evitare di fare il giro, io rimasi nei paraggi, esattamente fuori la porta dove si stavano riunendo. Aspettando che finissero, senza la minima paura. Tutto qui. Non c’è molto altro da fare”. Non riesco a capire come abbia fatto a fingere di non avere paura. Si può sorridere per finta, per finta essere allegri, per finta essere mafiosi, ma proprio non riesco immaginare come si faccia per finta a non provare paura. La provi e la scacci? Impossibile comprenderlo, sono meccanismi che puoi soltanto vivere, o meglio a cui puoi solo sopravvivere. Se sei fortunato. Gli dico così: “Ammiro questa tua capacità di aver tenuto separate le due vite. Secondo me è stato ciò che ti ha salvato l’anima”. Joe mi guarda con aria malinconica e non vuole rispondere altro che “Thanks”.
Iniziamo a mangiare, e così i toni si abbassano. Il registratore si riempie di suoni di posate che graffiano i piatti, di bicchieri che tintinnano per brindisi scemi che facciamo alle cose più disparate, “alla vita”, “in culo ai mafiosi”, “all’Italia”, “al Sud”. Riusciamo a stemperare ogni ansia e tensione iniziale, pronuncio persino il nome di Donnie Brasco ad alta voce, senza che Joe faccia altro che lanciare un’occhiata alla sala del ristorante per vedere le reazioni. Nulla.
Si può continuare a parlare, con tono normale. “Nel mio Paese”, gli argomento, “far parte della mafia significa avere sex appeal, e avere un seguito di groupie”. Joe Pistone conferma l’universalità della cosa. “In America è uguale. Poi, quando sei nella mafia ed entri in un ristorante ti danno i posti migliori. Lo stesso anche quando entri in un negozio di abbigliamento. Le donne, quando sei un boss, te la danno sul braccio…”. Usa sempre un’espressione che non conoscevo, ‘on the arm’, qualcosa di simile a ‘te la danno sull’unghia’.
Mi interrogo sul fatto se dopo anni passati in un certo modo, anche se difficili, quel tipo di vita possa mancarti, ma Joe è categorico: “No, non mi è mai mancata. Per me era solo un lavoro. Sono stato fortunato a crescere in un quartiere italiano dove la mafia era di casa: la conoscevo, e non mi affascinava. Non pensavo fosse niente di speciale”. Nel film invece il rapporto tra Depp e Pacino è tutto incentrato su una sorta di nostalgia. Brasco sa che perderà l’affetto di Lefty: che forse Lefty, appena si scoprirà che Brasco è un agente, potrà essere ucciso. Ma non è andata così, nella realtà. “Quando girano un film, devono far sì che l’eroe mostri i suoi sentimenti. Se l’eroe dice alla polizia: ‘Fate quello che volete di questa feccia, uccideteli. A me non importa’, allora gli sceneggiatori cambiano la scena perché al pubblico non piace. Ecco perché hanno voluto dare l’impressione che mi dispiacesse per la gente finita in galera o uccisa: per non dare l’impressione che il mio personaggio fosse senza cuore. Ma forse quando mi sono trasformato in Donnie Brasco sono diventato davvero senza cuore”.
Io che sono nato e cresciuto in un territorio dove molte persone a me care poi sono finite nei gangli della camorra, non sono mai riuscito a considerarle estranee agli affetti e alle emozioni perché sceglievano strade opposte alla mia. Non puoi costringere sempre i sentimenti a non voler bene a qualcuno perché vive facendo ciò che disprezzi e odi col cervello. Gli chiedo come ha fatto lui a non curarsi di questo rapporto naturale che nasce in certi territori e a denunciare coloro cui in fondo aveva voluto bene. Joe però è chiaro nel dire che non ha mai coinvolto nelle indagini persone che erano costrette a entrare in relazione con la mafia ma che non erano affiliate: “Ti capisco. Quando lavoravo sotto copertura per l’Fbi mi fu chiesto se avessi informazioni sulla gente del mio quartiere, gente che ho conosciuto crescendo. Gli ho detto no, perché ci ero vissuto. Alla fine è la stessa cosa nel sud Italia come a New York”.
In sei anni di copertura Joe Pistone è riuscito a vedere le tre figlie che vivevano nel New Jersey mentre lui operava a Manhattan una volta ogni sei mesi. Una privazione enorme. “Quando tornavo e credevo di essere ancora un padre, scoprivo che non lo ero più. Che ero abituato a essere un uomo senza famiglia e che la mia famiglia non era più abituata a me. Ma ero convinto di agire in nome di una società migliore, per un Paese migliore, sapevo che alla fine le mie figlie avrebbero avuto un beneficio da quello che facevo. Era l’unico modo possibile di vedere le cose. E la mia famiglia ha capito”. Pistone ha fatto arrestare circa 150 affiliati al clan Bonanno e su di lui c’è una taglia di 500 mila dollari mai ritirata, pronta a essere consegnata a chiunque faccia il piacere agli italoamericani mafiosi di Manhattan di eliminarlo. Ai processi dalla gabbia molti killer del clan, suoi ex amici, gli fecero il segno della pistola con la mano, puntandogli l’indice contro e mimando il suono dello sparo. Trovo il coraggio di ripetergli che non capisco come possa aver superato davvero la paura. Quando mi fu assegnata la scorta, il colonnello dei carabinieri Gaetano Maruccia mi disse citando Roosevelt: “L’unica cosa di cui avere paura è la paura stessa”. Un modo per consigliarmi di continuare il mio lavoro, di farlo serenamente e non cadere nella trappola dei clan di farti mettere addosso un’ansia continua e così allontanarti da te stesso. “Condivido pienamente”, dice Joe: “Non ho mai avuto davvero paura. Se ce l’hai, te la leggono in faccia. Ero sempre in allerta, sapevo sempre che se avessi fatto un errore potevo morire. E la paura ti fa fare errori”.
Certo, mi dico, ma dopo? Dopo che il lavoro sotto copertura è finito? Come fai a vivere serenamente? Non puoi continuare per decenni a non avere paura della paura, o no? “La mafia, abbiamo le prove, ha mandato gente proveniente da ogni angolo degli Stati Uniti per farmi fuori. In fondo dopo non era diverso da quando ero infiltrato: perché nella mia mente stavo facendo la stessa cosa. Facevo ciò che era giusto. E siccome era giusto, non c’era motivo di aver paura. Perché ero uno dei buoni. E fermati a pensare: cos’è il peggio che possono farti? Ucciderti? Non la vedevo una cosa così grave”.
Joe in fondo è un uomo semplice. In pace con se stesso. Ha sempre tenuto in mente che il suo era un lavoro, che lui era nel giusto, e che avrebbe fatto tutto il possibile per fare bene il suo lavoro. Non si è mai considerato né un eroe né un infame. Ma la famiglia, quel che ha dovuto passare la famiglia, non può essergli passato facilmente sulla coscienza. “Quello è stato il momento più duro per la mia vita. Quando la taglia sulla mia testa è stata estesa alla mia famiglia, e i miei familiari hanno dovuto farsi nuove identità, e trasferirsi altrove. Sì, mi sono sentito in colpa, perché non è una vita normale. Mai. Quando incontri nuova gente non puoi fare alcuna conversazione che riguardi il tuo passato, chi eri, cosa hai fatto. È dura per la famiglia. E questa situazione ha messo più costrizioni a loro che a me. Anche perché io so prendermi cura di me stesso”. Gli chiedo se abbia cercato di salvaguardare la sua memoria.
“La prima cosa che ho fatto è stata quella di lasciare a qualcuno il racconto della mia verità, così che se mi fosse successo qualcosa, ci sarebbe stata una persona in grado di restituirla. C’era un agente dell’Fbi cui avevo raccontato tutto. Era un mio amico. Ero amico anche del giudice Falcone”.
Poi è Joe che inizia a farmi le domande. Dice che fatica a immaginarsi una lotta antimafia con speranze di vincere in Italia. Si rende conto che oggi da noi la mafia è ancora più potente di quella che lui ha conosciuto ai tempi in cui era Donnie Brasco, quando i clan americani avevano agganci politici e controllavano oltre alla droga anche i trasporti, il business dei rifiuti e l’edilizia, tutte le ramificazioni che hanno continuato a coltivare e rafforzare qui. I boss italiani sono titolari di imprese, molti capizona hanno la laurea, i loro profili sono molto alti. È quasi sconvolto da questa ferocia borghese delle organizzazioni italiane. “Sai, i mafiosi americani sono gangster, sono considerati gangster e loro stessi si vedono come tali: partono dalla strada, come criminali comuni, e poi salgono i gradini dell’organizzazione. Solo nei classici del cinema li vedi fare la parte del businessman. Si sentono fuori dalla società ‘normale’, una casta a parte. Qui invece so che ci sono dottori e avvocati che ne fanno parte”.
Joe ha tentato di smontare il mito mafioso nelle sue relazioni di quando era Donnie Brasco. “Da noi gran parte dei mafiosi non si costruiscono ville e palazzi. La loro vanità si concentra sui vestiti, sulle macchine, sulle donne che frequentano. Non era difficile smontarli, non sono come i boss italiani che costruiscono la loro leggenda. Solo Gotti ha fatto così in Usa”. Detta da Joe, la cosa impressiona. Mi chiedo fino a che punto la mafia italoamericana sia stata attaccabile anche perché non ha mai sovrapposto la realtà al cinema, mentre la nostra ha seguito Hollywood, non solo facendosi costruire ville identiche, ma soprattutto volendo realizzare quei sogni di grandezza e di potere. E ci è riuscita. Non è possibile mentre si discute di questo non parlare dei ‘Soprano’s’, il telefilm che sembra aver cambiato il corso della storia televisiva e dell’immagine mafiosa negli Usa e in mezza Europa.
“In America la mafia la conoscono solo nelle città più grandi, come Chicago e Detroit, perché le attività mafiose si concentrano nelle aree industrializzate. In altre aree degli Stati Uniti – come nel Sud – l’influenza mafiosa non c’è, perché non c’è l’industria. Quindi possiamo dire che la ragione del suo grande successo da noi è che la gente era affascinata da qualcosa che spesso non conosceva, e dalla possibilità di vedere in tv il lato ‘buono’ della famiglia mafiosa, per quanto violenta e corrotta, che nessun’altra trasmissione aveva mai fatto vedere.
A me piacciono i Soprano’s, ma gli italoamericani si arrabbiano troppo, negli Usa ci sono organizzazioni nate apposta per tutelare l’immagine degli italoamericani. Può sembrare paradossale, ma negli Stati Uniti è molto comune, quando qualcuno ti incontra e scopre che sei italiano, sentirsi fare commenti tipo ‘allora sei membro della mafia’. Questo non lo sopporto”.
Gli racconto un episodio che lo riguarda: “Una volta un boss napoletano ha detto che Joe Pistone era diventato Donnie Brasco facendo fessi i Bonanno perché non aveva la faccia da mafioso, bensì da vero uomo. Invece gli amici dicevano, per prendermi in giro, che per me non c’erano speranze, con la faccia che mi ritrovo”. Joe ride: “Penso che a cose fatte è buffo che i boss sentano di dover ricorrere a queste scuse per giustificarsi. Li ho fregati e basta. Non ci sono scuse”.
Fregati e basta. Non per la faccia, ma per le altre qualità di cui mi accorgo di più, più la serata si rilassa e Joe Pistone continua a riempirsi il bicchiere. Joe sa squadrare le persone che ha davanti, le pesa con lo sguardo, ti vede i dettagli, sembra quasi che possa comprendere quando ti sei tagliato l’ultima volta le unghie e se nel portafogli porti dei santini.
Mi guarda, mi chiede della piastrina militare che porto al collo: “Dei paracadutisti vero?”. Poi vuole sapere: “Come mai indossi quei tre anelli?”. Cerco di spiegargli che è una vecchia usanza delle mie parti che porto più per tradizione che per credenza. Tre come Padre, Figlio e Spirito santo. “Bello”, mi dice. Anche a Joe piacciono i simboli da portare addosso. Lui mi mostra il Claddagh Ring, un simbolo irlandese di amicizia ed amore, un anello che condivide con la moglie. Sono sempre i dettagli che ti mostrano quanto la realtà sia superiore alla fantasia e fanno intuire quanto sia più grande di Johnny Depp questo signore ormai attempato, rubizzo e con la pancia. Come questa fede celtica, qualcosa che non c’entra nulla con Donnie Brasco e con tutto l’immaginario italo-americano, scelta per testimoniare il legame con la donna che gli è rimasta accanto tutta la vita, nonostante tutto.
Joe Pistone si alza. Abbiamo finito. Mi abbraccia fortissimo, raccogliendo le mie spalle nelle sue braccia poi tira fuori una macchina fotografica. Stefano stacca il registratore, si asciuga il sudore, anche lui abbraccia Joe. Poi si prende la macchina fotografica di Joe e inizia a metterci in posa. Io e Pistone sembriamo una coppia di turisti alticci. Anzi uno zio d’America che è venuto a trovare il nipote. Non ci curiamo più di non dare nell’occhio, ci alziamo nella sala del ristorante e iniziamo con i flash per scattare foto ricordo, di quelle orribili, ma capaci di fissare un momento troppo importante per badare alla bellezza delle immagini. Un clima strano, divertito, sereno. Joe indossa cappello e cappotto e se ne va. Ci riabbracciamo e mi dice guardandomi negli occhi: “Continuate, qui in Italia, c’è tutto da fare, siamo all’inizio”. Continuiamo. Promesso, Donnie, promesso Joe.
(L’Espresso, 4/2/2008)