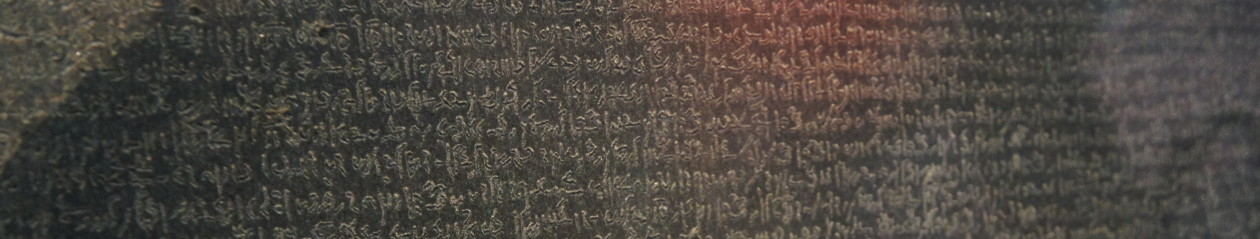Stefano Pitrelli, Europa
L’ONU E IL DOPOGUERRA IN IRAQ – Intervista a Marcus Raskin, analista americano dell’Institute for Policy Studies / Con la richiesta del segretario di stato americano, Colin Powell, dell’intervento di una forza internazionale in Iraq, gli Stati Uniti cercano ancora una volta di bypassare l’Onu, giocando d’anticipo. Così come era già successo prima della guerra in Iraq, quando l’amministrazione Bush chiedeva l’aiuto di una “coalizione dei volenterosi”, il tentativo è quello di creare una forza “terza” ad hoc, senza per questo rinunciare alle proprie prerogative sull’Iraq. E’ l’opinione di Marcus Raskin, analista dell’Institute for Policy Studies.
Il segretario di stato americano, Colin Powell, sembra tornato ad essere protagonista della crisi irachena. Ma cosa significherà questa rentrée, sulla strada (questa, almeno, ancora senza una mappa) per la ricostruzione dell’Iraq? Europa ha chiesto l’opinione di Marcus Raskin, cofondatore e membro dell’Institute for Policy Studies di Washington. Il professor Raskin è stato, tra l’altro, membro dello staff speciale del Consiglio nazionale di sicurezza dell’amministrazione Kennedy.
Professor Raskin, prima della guerra in Iraq, la coalizione angloamericana chiedeva l’aiuto dei paesi “volenterosi”. Oggi Powell chiede all’Onu più truppe, pur sotto un comando che resta saldamente in mano agli americani. Anche in questo caso, insomma, una forza internazionale “alternativa” alle Nazioni Unite?
Esatto, anche questa volta si tratta di un tentativo di outmaneuvering da parte degli Stati Uniti: bypassare l’Onu giocando d’anticipo. Anche in questo caso Colin Powell ha proposto una “forza internazionale”. Ma le altre nazioni non daranno il loro assenso a mandare le proprie truppe nel “condominio” internazionale senza ricevere delle garanzie. Quindi, stavolta l’outmaneuvering non sarà possibile, mettendo sotto grande pressione quella stessa strategia che aveva guidato la guerra: gli Stati Uniti possono cavarsela da soli, gli altri dovranno accettarlo. Ma il nazionalismo trionfalista era e resta tutt’ora l’idea motrice.
Come sono cambiati i rapporti Usa-Onu, dopo l’attentato alla sede delle Nazioni Unite di Bagdad?
I rapporti tra gli Stati Uniti e le Nazioni Unite sono ancora nel pieno di un processo evolutivo, ed esistono molti punti divista diversi riguardo a cosa dovrebbe esser fatto. Il primo è quello secondo il quale l’Onu dovrebbe continuare ad essere uno strumento per risolvere quei problemi lasciati irrisolti in Iraq dalla guerra. E con questo voglio dire che assomiglierebbe molto all’immagine della moglie/madre che pulisce e riordina il casino che il marito/figlio ha lasciato in casa. Insomma, fare il lavoro duro e sporco della ricostruzione, mentre in ogni caso gli Stati Uniti continuerebbero ad essere la nazione che dirige le operazioni militari e controlla l’Iraq. In questa prospettiva, qualunque forza internazionale entrasse in Iraq sarebbe comunque sotto il comando americano.
E la seconda?
La seconda è quella in virtù della quale gli Stati Uniti devono lasciare l’Iraq. E qui la scelta si dirama: da un lato quelli che dicono “andatevene il prima possibile”, e lasciate il problema a un qualche “condominio internazionale”. E’ qualcosa di molto vago, per il semplice fatto che non esiste un condominio cui affidare il tutto. Ma ancora, se gli Stati Uniti volessero coinvolgere altre nazioni, o anche le stesse Nazioni Unite, dovrebbero pagare. Così la domanda è, come farebbero? Con contratti petroliferi? Con ampie somme di denaro per la ricostruzione del dopoguerra? Si tratterebbe, dunque di pagare perché le Nazioni Unite prendano su di sé la loro responabilità. Dall’altro, c’è chi spinge per chiamare in aiuto la Lega araba con lo scopo di aiutare nella ricostruzione.
La ragione? Potrebbe esserci più apertura da parte degli iracheni se altre nazioni del Medio oriente fossero coinvolte nel progetto. Guardando a queste possibili alternative – e alle altre che non sono state prese in considerazione – ci si rende conto che gli Stati Uniti si trovano in una situazione veramente difficile.
E come la sta affrontando, l’amministrazione Bush?
All’interno dell’amministrazione c’è chi ritiene che bisognerebbe andare fino in fondo, a meno di rischiare una crisi di fede. Occupare, pacificare e infine costruire una specie di nazione, di democrazia. E’ la posizione più significativa nell’amministrazione. Ma non è condivisa dal congresso. Tra i repubblicani c’è chi preferirebbe semplicemente andarsene. C’è chi vorrebbe inviare ancor più soldati, chiamare le riserve per aumentare la forza americana in loco e continuare la guerra.
Si parla sempre di più dell’Iraq come di un Vietnam di sabbia. E’ un’analogia che condivide?
Il problema è che ci si sta infilando in un pantano. Proprio come nel Vietnam: la guerra può crescere e crescere di dimensioni, se gli Stati Uniti aumentano il loro coinvolgimento. Ma la preoccupazione principale, per l’amministrazione, viene dall’opinione pubblica.
La richiesta da parte del segretario di stato di più truppe può rappresentare un segno di rafforzamento dell’influenza dei “neocon” sull’amministrazione?
Non è un segno di rafforzamento. La grande forza ideologica dietro alla posizione dei “neoconservatives” sul tema della guerra inizierà a svanire, e per molte ragioni. A partire dal costo della guerra, in termini meramente economici. E in secondo luogo, se le riserve verranno richiamate, le famiglie dei militari verranno sempre più a pesare, con un effetto politico significativo sul congresso. Senza contare che, col passar del tempo, resta difficile ricostruire o ottenere il petrolio, e questo rappresenta un problema per le corporation.
Non stanno ottenendo ciò che volevano, perché non c’è abbastanza stabilità in Iraq.
(Europa, 23/8/2003)